- News
- Recensioni e segnalazioni librarie
BILL GATES & IL FUTURO DEL LAVORO
Franco Piccinini ci illustra il futuro del lavoro secondo Bill Gates.
Data di pubblicazione:

Franco Piccinini ci illustra il futuro del lavoro secondo Bill Gates.
Data di pubblicazione:

In una recente intervista Bill Gates, il fondatore di Microsoft, ha sostenuto che l’introduzione su larga scala dell’uso dell’intelligenza artificiale porterà a una riduzione generale della necessità di lavorare, per cui è prevedibile che in futuro la settimana lavorativa sarà di soli due giorni a persona (fonte: Il Sole 24 ore – maggio 2025). Secondo il quotidiano di Confindustria: “L’aveva detto in tempi non sospetti, l’ha ripetuto qualche giorno fa … secondo Bill Gates in meno di un decennio l’umanità potrà lavorare appena due giorni alla settimana. Grazie, ovviamente, all’intelligenza artificiale. Al ritmo attuale dell’innovazione, il padre di Microsoft prevede che gli esseri umani non saranno più necessari «per la maggior parte delle cose», e quindi sarà presto necessario ripensare il concetto stesso di lavoro. Secondo Gates saranno le professioni sanitarie e quelle legate all’insegnamento a trasformarsi più velocemente.” L’affermazione ha fatto molto scalpore, ma si tratta della scoperta della H2O calda. Non voglio diminuire l’importanza della dichiarazione di Gates, considerato che è uno dei principali responsabili della rivoluzione digitale, ma in realtà filosofi, sociologi, sindacalisti e scrittori di fantascienza lo andavano ripetendo da molto tempo. Una delle migliori riflessioni su questo argomento è contenuta nella lunga intervista al compianto professor Domenico De Masi, da poco scomparso. Nel suo libro “Conversazioni sul futuro”, pubblicato all’inizio del 2025 da Paper First, De Masi ci lascia le sue riflessioni sul futuro della nostra società sotto forma di una lunga intervista. È il risultato di una serie di incontri tra De Masi e l’amico giornalista Giulio Gambino, avvenuti tra il dicembre 2021 e il maggio 2023 nella casa romana del professore. Lo consiglio caldamente. Si tratta d’un vero e proprio testamento morale, rilasciato in previsione della sua scomparsa. De Masi affronta con grande lucidità alcuni fra gli argomenti più preoccupanti del nostro tempo, vale a dire i problemi esistenziali dell’uomo nell’età post-industriale. Sono questioni che, nonostante le spinte al cambiamento legate all’era digitale, all’automazione e all’intelligenza artificiale, rimangono le stesse dall’inizio dell’Ottocento: l’alienazione del lavoro, la riduzione dell’orario, lo smart working, la necessità di un salario minimo, l’aumento del tempo libero disponibile, l’ozio creativo. Si discute anche del diritto a essere felici, ma questa non è un’idea di De Masi e non è nemmeno una novità: è contenuta nella dichiarazione d’indipendenza degli USA del 4 luglio 1776 ed è stata ripresa nella Carta dei Diritti dell’Uomo dell’ONU nel 1948. È tutto da discutere invece se la riduzione della necessità di lavorare per guadagnarsi da vivere sarà davvero realizzata e messa a disposizione di tutti, oppure se si trasformerà nell’ennesima forma di prevaricazione dell’uomo sull’uomo.
È qui che intervengono le riflessioni degli scrittori di fantascienza. La frase di Bill Gates mi ha subito fatto tornare alla mente una famosa illustrazione di copertina di Virgil Finlay, in cui si vede un astronauta seduto a un crocicchio di strada che chiede l’elemosina. Ha degli occhiali scuri da cieco e si presume che questo gli impedisca di volare ancora nello spazio. Un robot si ferma e gli mette dentro l’elmetto un piccolo obolo: un perfetto simbolo di quanto l’automazione potrà danneggiare il mondo del lavoro. Sono immagini e riflessioni soprattutto legati al periodo che va dagli anni Cinquanta ai primi anni Sessanta del secolo scorso. Nel decennio precedente, infatti, l’entusiasmo per le nuove scoperte scientifiche e per le acquisizioni dell’astronomia aveva portato gli scrittori a raccontare vicende che coinvolgevano scienziati e inventori, oppure viaggiatori, esploratori e avventurieri: tutta gente votata ad affrontare lo spazio cosmico e il futuro che avanzava (sto semplificando, naturalmente). Superata questa fase di entusiasmo, nel decennio successivo, anche per effetto delle prime bombe atomiche, gli scrittori iniziarono ad occuparsi degli effetti che i cambiamenti sociali del futuro avrebbero avuto sulla gente comune e i nuovi protagonisti diventano così operai, impiegati, casalinghe, affaristi, lavoratrici: tutti alle prese con cambiamenti su cui non hanno alcun controllo.
Automazione e consumismo
La meccanizzazione dell’agricoltura e l’automazione totale nella produzione industriale porteranno inevitabilmente a una sempre maggiore diminuzione della necessità di operatori umani per la produzione di beni materiali. Contemporaneamente, il modello attuale di sviluppo comporterà una sempre maggiore necessità di produrre nuovi beni di consumo, possibilmente deteriorabili in modo da garantirne un rapido turnover. L’unione di questi due fattori ha spinto Philip K. Dick a immaginare nel futuro le Autofac. Sono fabbriche completamente automatizzate (il neologismo ideato da Dick è la contrazione di auto – factory) e dirette da computer senza intervento umano. Nel racconto “Autofac” del 1955, durante il Conflitto Globale Totale è stata allestita una rete di fabbriche automatiche rinforzate con controlli cibernetici, in grado di determinare da sole quali alimenti e beni di consumo produrre e consegnare. La Guerra è finita e il mondo è semidistrutto e impoverito, ma le fabbriche continuano a produrre oggetti ormai inutili e non accettano più il controllo umano. Si cerca di distruggere le filiere di consegna, ma i cervelli cibernetici aggirano tutti gli ostacoli e continuano a produrre lavatrici, frullatori, tostapane e a gettarli fuori. Ogni sabotaggio fallisce e alla fine escono addirittura nuovi oggetti completamente indistruttibili. Non solo: la fabbrica è diventata auto-replicante e sta inviando semenze metalliche configurate per creare altre autofac in miniatura. Un incubo assoluto, che ha pochi eguali nella fantascienza.
Per stare su un livello più divertente, o almeno non così spaventoso, ricordo qui il racconto di James Gunn “Piccolo androide orfano” (Little Orphan Android) sempre del 1955. Il protagonista è un manager che accetta di accogliere in casa un automa dalle caratteristiche sperimentali, molto differente da quelli che si producono generalmente. Il titolo è volutamente ispirato a una famosa serie americana a fumetti del tipo “strappalacrime”: Annie l’orfanella, ovvero Little Orphan Annie. Ma l’automa è più maldestro di un bambino piccolo e fa un sacco di danni involontari in casa: rompe mobili e suppellettili, inciampa, danneggia il bagno eccetera. Alla fine il protagonista scopre che l’incapacità dell’androide è accuratamente programmata. Serve ad aumentare la velocità con cui i beni di consumo vengono distrutti, in modo da accelerare la produzione dei nuovi modelli. Tutto considerato, anche questo è un bell’incubo, no?
Intelligenza Artificiale
Se l’automazione è destinata a far scomparire il lavoro manuale, l’introduzione della IA porterà alla disoccupazione intellettuale. Nel 1957 Isaac Asimov scrive uno dei suoi famosi racconti sui robot: “Il correttore di bozze” (Galley Slave). Qui troviamo una fabbrica di robot umanoidi, la U.S. Robots, che decide di fornire a poco prezzo uno dei suoi robot a una università. L’idea è di colonizzare gradualmente l’intero mondo accademico. Il professor Ninheimer affida al robot il suo ultimo libro, salvo poi accorgersi dei guai che l’automa ha combinato: il libro presenta numerose differenze dalle bozze originali, e non di natura grammaticale, come ci si aspetterebbe, ma di natura concettuale. Molti colleghi e amici del professore, leggono il libro e, offesi e furiosi, minacciano azioni legali contro l’autore. Il professore alla fine è costretto a confessare di aver ordinato lui stesso al robot sia di apportare quelle modifiche, sia di non svelare quanto fatto. Ma perché compiere un gesto simile, che gli ha rovinarlo la carriera? Ninheimer intendeva difendere i futuri ricercatori da una catastrofe: i robot saranno destinati in futuro a svolgere sempre più funzioni e allo scrittore, all’artista, all’artigiano, non resterà che impartire solo ordini. Nulla verrà materialmente creato dalle mani dell’essere umano: nessun libro, nessun dipinto, nessun vaso sarà fatto realmente da un uomo. È ESATTAMENTE ciò che sta succedendo oggi. Quasi come se avesse immaginato un futuro alternativo a partire da questo racconto, Fritz Leiber ci descrive come sarà il futuro della letteratura, dopo l’intervento della intelligenza artificiale. Nel suo romanzo “Le argentee teste d’uovo” (The Silver Eggheads, 1961) ci porta in uno scenario culturale futuro nel quale gli scrittori firmano opere composte da macchinari, chiamati mulini-a-parole (il termine IA non era ancora di moda). Gli scrittori stessi si limitano a recitare in pubblico i ruoli descritti per loro nelle contro copertine e firmare le copie dei libri. Solo i colleghi robot (che hanno da poco raggiunto l’emancipazione e l’indipendenza) scrivono sul serio. Ma per un pubblico di robot, com’è ovvio. Il protagonista Gaspard De La Nuit (nome scelto per lui dall’editore, come anche la sua attuale fidanzata) ha un solo amico, il robot-scrittore Zane Gort (notare prego il gioco di parole del nome, che fonde l’autore di western Zane Grey con il robot di Ultimatum alla Terra…). Finché un giorno gli scrittori inferociti distruggono tutti i mulini-a-parole, salvo poi dover affrontare una grave crisi di creatività: nessuno sa più scrivere davvero. Se non i robot.
Non è secondaria la questione di quanta parte dei meccanismi che fanno funzionare la nostra società possiamo affidare senza controllo umano a queste intelligenze artificiali. Tra i numerosi racconti ammonitori su questo tema, uno dei miei preferiti è “Automazione integrale” (Dial F for Frankenstein) un racconto di Arthur C. Clarke apparso su Playboy nel 1965. Supponiamo di aver affidato a un super – computer le linee telefoniche, le condutture di gas e acqua, le ferrovie e le metropolitane, le trasmissioni televisive, i satelliti artificiali, gli aeroporti e così via. E magari anche il lancio dei missili nucleari. Ma se poi il cervello centrale acquisisse una propria autocoscienza? E se decidesse che non vuole essere spento perché lo spegnimento per lui equivale alla morte? (Quattro anni più tardi Clarke e Kubrik avrebbero espresso lo stesso concetto per il computer HAL 9000 del film Odissea nello Spazio). Come potremmo fermarlo, dopo avergli dato il controllo di TUTTO?
Lavorare meno, lavorare tutti (?)
L’idea che la diminuzione della necessità di lavorare porterà all’utopia proposta dal Bill Gates è allettante, ma è, per l’appunto, un’utopia. Alcune nazioni come la Francia e la Spagna, più avanzate nell’ambito dei diritti civili, hanno provato delle riforme che vanno in questa direzione e, apparentemente, il sistema sembra funzionare, senza riduzione della produttività. Anzi, con un leggero aumento. Ma qui ci si scontra con uno dei difetti fondamentali dell’essere umano: la spinta a prevaricare e a sfruttare i propri simili. Negli anni Cinquanta Robert A. Heinlein scrisse un saggio dal titolo “Pandora’s Box” (Il vaso di Pandora) in cui faceva una serie di previsioni ragionate sull’evoluzione che avrebbe avuto la società, per effetto dei risultati del progresso scientifico (lui la chiama “estrapolazione”). Prevedeva più benessere per tutti, meno malattie e soprattutto meno necessità di lavorare. Nel 1967 venne ristampato il saggio e in molti obiettarono allo scrittore che parecchie sue previsioni non si stavano avverando. La risposta di Heinlein è stata lapidaria: “non avevo tenuto abbastanza conto della stupidità umana”.
Secondo Adamo Smith l’avidità di guadagno è cosa buona e giusta e aiuta il progresso. Di sicuro, aiutare il prossimo e re-distribuire la ricchezza non sembra una caratteristica diffusa nella maggior parte degli esseri umani. Ce ne fornisce un buon esempio il racconto di Robert Sheckley “Carovita” (Cost of Living, 1952): vi si delinea un futuro in cui gli acquisti a rate e l’indebitamento delle famiglie arrivano a un punto tale che il debito da pagare diventa per legge EREDITARIO. Il passo successivo è la schiavitù per debiti, come avveniva nell’Europa del Diciottesimo Secolo e come accade ancora in posti lontani come l’India. Siamo sicuri che non succederà di nuovo? Qualcuno ci sta probabilmente già pensando…
C’è anche la questione di che cosa fare di tutta questa massa di persone non disoccupate ma INOCCUPATE, vale a dire senza alcuna possibilità di trovare un lavoro. In “La gente intorno a noi” (Subsistence Level, 1954) sempre Sheckley immaginava che questi poveracci potrebbero essere indotti a emigrare nello spazio, colonizzando la fascia degli asteroidi e i pianeti esterni, accettando i sacrifici nell’illusione di una vita migliore per i propri discendenti: un po’ come è accaduto per i poveri d’Europa quando è stata aperta la colonizzazione delle Americhe (e come si vede nel film “Bladerunner”). Il racconto ha per protagonisti una coppia di sposi. Il marito ha un desiderio innato di esplorare, colonizzare e vivere in spazi solitari per migliorare la loro vita. La moglie cerca di assecondarlo, decisa a salvare il matrimonio. I due così si spostano dal pianeta Terra fino agli asteroidi, come i pionieri americani dei secoli passati. Nel ritrarre i personaggi non manca una vena ironica e umoristica, tipica di Sheckley. Ad esempio, l’autore fa notare il numero enorme di ore di lavoro quotidiano del marito (cinque!) e le fatiche domestiche della moglie (accendere e spegnere i robot domestici!). Quasi a voler dare un seguito alla vicenda, Sheckley immagina la fine di uno di questi coloni nel racconto “Reqiem automatico” (Beside still waters, 1954). Scritta senza il solito tono sardonico, sobria e commossa come un racconto di Hemingway, è la storia d’un ricercatore minerario della fascia degli asteroidi. Rimasto solo, condivide gli ultimi anni della sua vita con un robot, che assume connotati sempre più umani. Quando il colono muore viene seppellito dal robot, che recita per lui il Salmo 23 (quello citato nel titolo originale): “Il Signore è il mio pastore; non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare; ad acque tranquille mi conduce”. Purtroppo la frontiera dello spazio oggi non sembra offrire alcuna prospettiva, mentre il numero di quelli che non lavorano aumenta.
E non si parla più soltanto dei lavoratori manuali, poiché l’avvento delle IA sta portando anche a una disoccupazione dei lavori impiegatizi e intellettuali. Lo aveva visto molto bene K. M. O’Donnell (aka Barry Malzberg) nel racconto del 1969 “Tutti i miei cari assistiti” (How I Take Their Measure). Qui abbiamo un assistente sociale che si occupa di assegnare sussidi a ricercatori, professori universitari, intellettuali e impiegati di alto livello, perché sono ormai tutti disoccupati. Ma lui, che non ha finito gli studi, odia quella gente, per la quale aveva un complesso di inferiorità, e si diverte a vessarli, maltrattarli e, talvolta, a fargli mancare l’assegno mensile. È più probabile che sia questo il futuro preparato per noi dall’arrivo massiccio della intelligenza artificiale, piuttosto che quello roseo prospettato da Bill Gates.
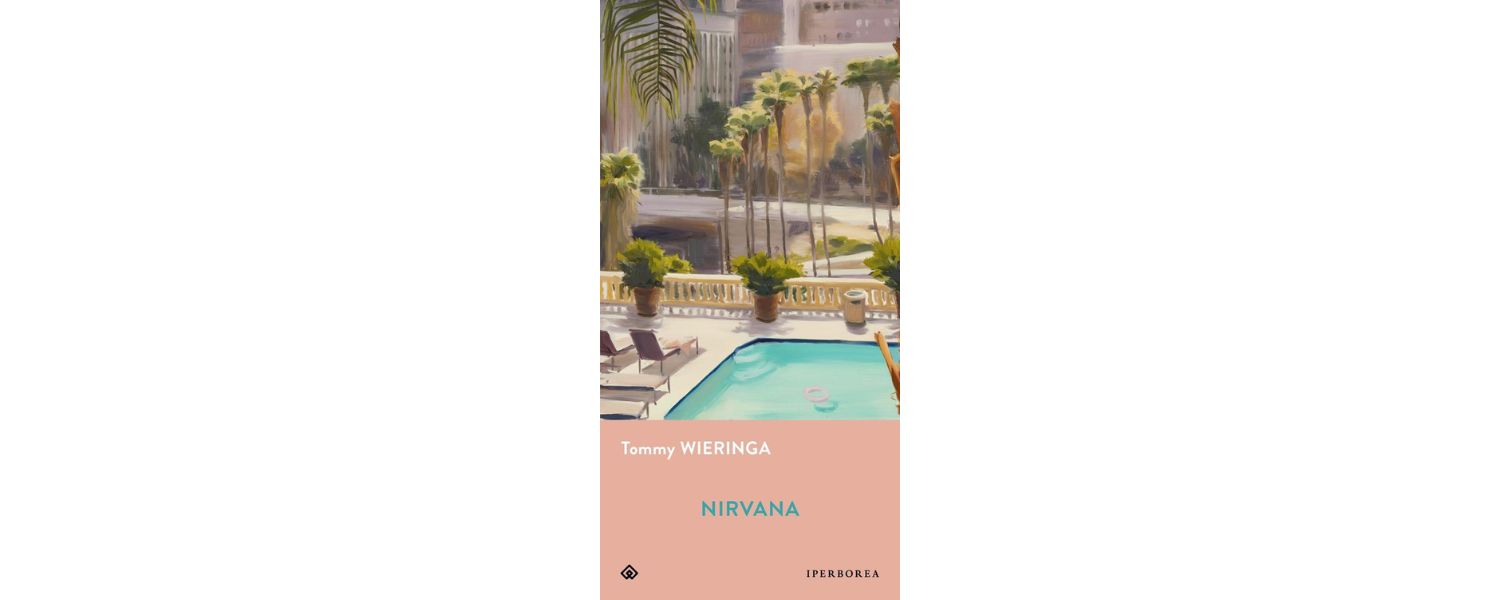
Luigi Dell’Orbo ci porta alla scoperta del libro “Nirvana” di Tommy Wieringa.
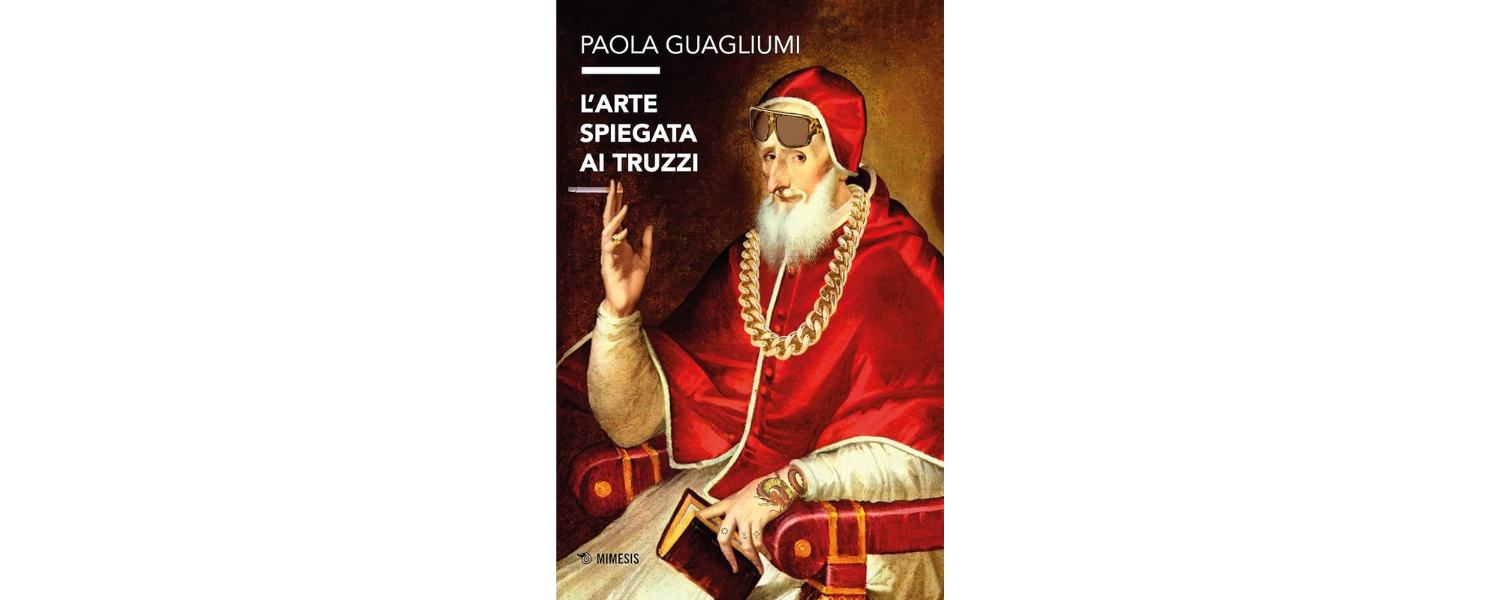
Franco Piccinini ci propone la sua recensione del libro di Paola Guagliumi dal titolo ‘L’arte spiegata ai truzzi’.